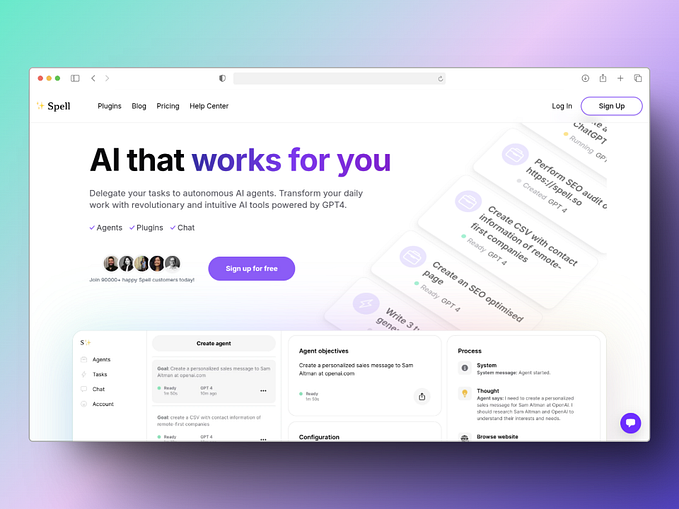Harari, l’arte e i dati

In questi giorni sto leggendo “Homo Deus: breve storia del futuro” di Yuval Noah Harari. Non avevo mai letto nulla di suo e devo ammettere di essere stato molto curioso, anche perché è un storico di successo che è poco più giovane di me e, quindi, volevo avere un confronto “storico”.
Non sono stato deluso: c’è molta ricchezza, scrive molto bene e fa degli esempi molto calzanti, che ti calano pragmaticamente e concretamente nel suo punto di vista. Per un po’ ti fa anche smettere di pensare al fatto che, come è nella vita, per un esempio che fa a favore della sua prospettiva, se ne potrebbero fare altri 64 che portano in direzioni drammaticamente differenti.
Il gioco della “concretezza” e degli “esempi” è un gioco retorico sporco, e lo sappiamo. Quando, in una discussione, l’altro ti dice “e fammi un esempio, ma pratico!” sai già che si sta per litigare:)
Oltretutto, ho capito perché Harari, nonostante assuma anche posizioni molto critiche, sia così amato in Silicon Valley: è una sorta di guru dell’egemonia culturale made in California per cui, nonostante l’abbondanza di alternative — anche dati alla mano — , lui ne è sicuro: l’evoluzione dell’essere umano è quella lì, in cui le IA sono quella cosa lì, il corpo cambierà così, la salute cambierà cosà, eccetetera. Sembra di leggere 500 pagine di TED talks, ci sono idee per mille e una startup e, citando a braccio da un articolo sul New York Times: “la storia è nata con l’invenzione delle religioni, e finirà quando gli esseri umani diventeranno dèi”. Elon Musk non avrebbe saputo dirlo meglio. Fatti fare delle dispense, Elon, se già non le hai.
Potrei continuare molto, ma non lo farò: leggetevi il libro, e poi parliamone insieme, se volete. Qui mi concentrerò su una cosa sola.
A un certo punto del libro sono arrivato a definizione di cosa sia l’arte.
Riporto un tratto del testo:
Si dice spesso che l’arte rappresenta il nostro massimo (e unicamente umano) santuario. […] Tuttavia, non si comprende perché la creazione artistica dovrebbe fare eccezione e restare inaccessibile agli algoritmi. Perché siamo così fiduciosi che i computer non saranno mai in grado di superarci nella composizione musicale? Secondo le scienze biologiche, l’arte non è il prodotto di un qualche spirito incantato o un’anima metafisica, ma piuttosto l’esito di algoritmi organici in grado di riconoscere pattern matematici.
E ho capito.
Due note al volo:
- Harari fa molti esempi musicali (tra l’altro tralasciando sistematicamente il ruolo della relazione tra il programmare e l’essere programmato, ma glielo abbuoniamo, perché iniziano già ad esserci cose che si programmano da sé, ma si tratta sempre di problemi uovo/gallina che, come è facile intuire, sono domande poste molto male), un po’ sulle altre arti “classiche” e poche altre cose; pare che la sua idea di arte sia ferma all’800.
- Si parla delle “scienze biologiche”: e le altre? È un altro giochino sporco: si vuole far passare un discorso generale, praticamente universale, però poi si ragiona per silos, come più conviene.
Harari, più che uno storico, si dimostra un “ingegnere” dell’arte. La butta sull’efficienza.
L’arte, così, diventa un fenomeno che avviene perché che si possa concentrarsi sull’efficacia di “fare delle cose” (colorate, sonore o cos’altro) per stimolare i neuroni a passare da stato A a stato B. È questo “l’esito di algoritmi organici in grado di riconoscere pattern matematici”, in modo da farci sopravvivere.
Non dico neanche che non sia giusto. Dico che lascia troppo cose indietro per essere una definizione interessante.
Questa definizione “ingegneristica” dell’arte è perfetta anche per mostrare cosa non (mi) torni nel suo libro: perde moltissimo del mondo. L’arte interagisce con la psicologia, la cultura, la comunicazione, con i nostri segni e i nostri simboli, con la nostra relazionalità, con la società, con la politica, con la nostra sensualità, con i nostri diritti e le nostre libertà. Anche se fosse un discorso logico, siamo sicuri di voler ridurre l’arte alla dimensione di utile strumento per un’evoluzione efficace? Cosa ci staremmo perdendo? Siamo sicuri che non ci sia qualche elemento di necessità (e/o, addirittura, di sufficienze) anche in questa cosa che ci staremmo perdendo? (Domanda, tra l’altro, ripresa proprio nell’ultima parte del libro, ma anche lì la risposta — sotto forma di altra domanda e di un elenco di “compiti a casa” — non è soddisfacente. Ma non faccio altri spoiler.
Uno possibile soluzione sarebbe quella di estendere di molto la definizione di cosa è arte: arte è quella cosa che quando la fai i tuoi neuroni e quelli dei tuoi amici passano da A a B.
Mi sembrano questioni poste male.
E Harari stesso svela, in un certo senso il perché, quando arriva la parte del libro che parla di cosa viene dopo la “religione umanistica”. Tra le minacce per la visione liberista, Harari mette il drastico calo della rilevanza strategica dell’individualità (e quindi, per quello che ne risulta, anche della società e dell’ecologia, intesi come gli spazi in cui coesista la diversità).
La definizione di arte data dallo scrittore è in armonia con questa visione.
Innazitutto perché presuppone che il “chi” dell’arte sia ininfluente.
Il chi crea l’arte. Il che, oltretutto, sta cambiando, e non nel senso — banale — delle IA che diventano artisti. Chi addestra le IA per “fare l’artista” e programma il software per portare a fruizione questa “arte” sa di che parlo. Stiamo avendo, invece, una esperienza completamente diversa, nel senso delle nuove alleanze che si formano per fare arte, tra artisti, comunità, territori, scienziati, istituzioni commoventi, agenti computazionali, ambiente e tanti altri attori.
E il chi la fruisce l’arte, chi ne gode. E anche lì sta cambiando tutto. Non solo nei termini delle evoluzioni dei gusti e delle sensibilità dei pubblici. Ma anche in modo radicale, perché anche solo dando la definizione semplicistica e rozza di Harari, iniziamo ad avere esprerienza pratica di opere d’arte pensate
- per le organizzazioni (quali sono i “neuroni” delle organizzazioni? i dipendenti? i direttori? i team? altro?),
- per gli agenti computazionali (le IA, le piattaforme etc: possono essere il “pubblico”, il fruitore dell’arte? che vuol dire?),
- per gli organismi e gli elementi dell’ambiente (può un bosco o il mare essere un artista? Nelle alleanze del Nuovo Abitare di cui parliamo, possono, certamente)
Possono essere questi attori fruitori dell’arte? Come “gode” un bosco?
Siamo sempre allo stesso punto: domande che, se fossimo intelligenti, cercheremmo di porre in un altro modo.
Per esempio un modo ecologico. L’ecologia: la scienza delle relazioni.
Perché di una cosa possiamo essere certi: che alla base fondamentale di queste cose di cui stiamo parlando c’è sempre una qualche forma di relazione. Che può essere ortodossa, tra esseri umani, se proprio vogliamo. Ma che più probabilmente è di tipo più esteso, perché ora, nel mondo in cui viviamo adesso, nella sua globalizzazione e iperconnessione, tra reti, sensori, dati e agenti computazionali, entriamo sempre più in contatto con il non umano.
Qui le relazioni si fanno strane, queer: tra umani, alberi, corporation, territori, algoritmi, istituzioni, virus e chissà cos’altro ci inventeremo. Tutti uniti dai dati, che diventano un common ground esistenziale. Con la conseguenza che anche quello che chiamiamo “dati” sta cambiando.
E perciò arriviamo a un’altra cosa che ho letto:
È un articolo molto bello, che tra l’altro menziona anche Harari, tra tanti altri.
Sin dal titolo, però, non mi tornava qualcosa. Perché quel “non solo dati”, suonava proprio strano. Come se i “dati” fossero qualcos’altro da noi.
Negli anni del COVID ce ne dovremmo essere accorti ormai. I dati — in questa scala e con questa ubiquità — sono una componente esistenziale: nostra, del nostro ambiente, delle nostre organizzazioni etc.
Come dice anche Harari: sull’esistenza del libero arbitrio la scienza ha sollevato più di qualche dubbio, sul fatto che una larga fetta dei miei diritti e delle mie libertà dipendano dai dati e dalla computazione, ormai, proprio no.
Dai dati dipendono anche le mie opportunità di comprendere ed avere esperienza del cambiamento climatico, della pandemia e degli altri fenomeni complessi del nostro tempo: che siano la povertà, l’educazione e tutti gli altri.
Anche qui: non pecchiamo di ingenuità. Non posso avere esperienza della presenza del cambiamento climatico, o comunicarla, dipingendo un quadro di un tramonto.
Mi servono i dati che, come suggerisce l’articolo, possono diventare cose anche strane, se confrontate con quello che fino a poco tempo fa chiamavamo dati. Il dipinto di Turner e gli altri meravigliosi quadri di cui parla l’articolo, sono trattati come dati: elementi culturali che diventano sensori, in quanto usando la pittura per memorizzare in qualche modo alcune caratteristiche dell’ambiente. I quadri descritti nell’articolo diventano meravigliose (seppur imprecise) visualizzazioni di dati. Ma sarebbero inutili senza la cultura, ovvero quello che ci tiene insieme, per avere esperienza comune del mondo, per commuoversi e muoversi insieme.
Per avere esperienza del cambiamento climatico servono enormi quantità e qualità di dati. Peccato che non abbiamo un “senso” per i dati. E quindi questi dati devono essere trasformati in qualcosa che sia adatto alle sensibilità delle dozzine di sensi, interni ed esterni, di cui siamo dotati. In questa trasformazione, a volte, nel processo che noi chiamiamo Datapoiesi, questi sensi aumentati, queste sensibilità del nuovo abitare, diventano opere d’arte. Perché oltre a farci sentire sulla pelle questi fenomeni (effettivamente facendo passare i nostri neuroni dallo stato A allo stato B), riescono nell’intento di creare relazioni, conversazioni, simbologie, luoghi o oggetti attorno a cui riunirsi. Dei totem queer attorno a cui sedersi per avere esperienza di questa strana realtà, oltre i nostri sensi, di cui possiamo avere esperienza solo tramite queste nuove alleanze tra esseri umani, organismi ed entità dell’ambiente, personalità giuridiche, agenti computazionali.